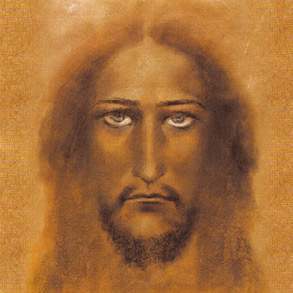VOLUME III CAPITOLO 168
CLXVIII. Aglae in casa di Maria a Nazareth.
20 maggio 1945. Pentecoste.
168.1 Maria lavora quieta ad una tela. È sera, tutte le porte sono chiuse, una lucerna a tre becchi illumina la piccola stanza di Nazaret e specie la tavola presso cui è seduta la Vergine. La tela, forse un lenzuolo, ricade dal cassapanco e dai ginocchi fino a terra e Maria, vestita di azzurro cupo, pare emergere da un mucchio di neve. È sola. Cuce lesta, col capo chino verso il suo lavoro, e il lume accende il sommo del suo capo con riflessi di pallido oro. Il resto del volto è in penombra.
Nella stanza ben ordinata regna il massimo silenzio. Anche dalla via, deserta nella notte, non viene rumore. E dall’orto neppure. La pesante porta che dalla stanza dove Maria lavora, quella dove Ella è solita prendere i suoi pasti e ricevere gli amici, conduce all’orto, è chiusa e impedisce anche al rumore della fontanella, che spiccia nella vasca, di penetrare. È proprio il silenzio più profondo. Vorrei sapere dove è il pensiero della Vergine mentre le sue mani lavorano leste… Un bussare discreto all’uscio che dà sulla via. Maria alza il capo, ascolta… È stato così lieve il bussare che Maria deve pensare che è causato da qualche animale notturno o da un poco di vento che abbia scosso la porta, e torna a chinare la testa sul lavoro. Ma il busso si ripete più distinto. Maria si alza e va verso la porta. Chiede, prima di aprire: «Chi bussa?».

Risponde una voce sottile: «Una donna. In nome di Gesù, pietà di me».
Maria apre subito, tenendo sollevata la lampada per conoscere questa pellegrina. Vede un ammasso di stoffa, un viluppo da cui nulla traspare. Un povero viluppo che sta curvo in profondo inchino dicendo: «Ave! Domina!», e ripete ancora:
«In nome di Gesù, pietà di me».
«Entra e dimmi che vuoi. Io non ti conosco».
«Nessuno e molti mi conoscono, Domina. Mi conosce il Vizio. E mi conosce la Santità. Ma ho bisogno che ora la Pietà mi apra le braccia. E la Pietà sei tu…», e piange.
«Ma entra dunque… E dimmi… Hai detto abbastanza perché io comprenda che sei una infelice… Ma chi sei non lo so ancora. Il tuo nome, sorella…».
«Oh! no! Non sorella! Io non ti posso essere sorella… Tu sei la Madre del Bene… io… io sono il Male…», e piange sempre più forte sotto il suo manto calato a nasconderla tutta.
Maria posa la lucerna su un sedile, prende la mano della sconosciuta inginocchiata sulla soglia, la obbliga ad alzarsi.
168.2 Maria non la conosce… io sì. È la velata dell’Acqua Speciosa.
Si alza, avvilita, tremante, scossa dal suo pianto, e ancora resiste ad entrare dicendo: «Sono pagana, Domina. Per voi ebrei: lordura, anche se fossi santa. Doppia lordura perché sono una meretrice».
«Se vieni a me, se cerchi il Figlio mio attraverso me, non puoi più che essere un cuore che si pente. Questa casa accoglie chi ha nome Dolore»; e la attira dentro chiudendo la porta, rimettendo il lume sul tavolo, offrendole un sedile, dicendole:
«Parla».
Ma la velata non vuole sedere; un poco curva, continua il suo pianto. Maria è davanti a lei dolce e maestosa. Attende, pregando, che il pianto si calmi. La vedo pregare con tutto il suo aspetto, per quanto nulla prenda in Lei forma di preghiera. Né le mani, che sempre tengono fra le sue la piccola mano della velata, né le labbra che sono chiuse.
Infine il pianto si calma. La velata si asciuga il volto col suo velo e poi dice: «Eppure, non sono venuta da tanto lontano per rimanere ignota. È l’ora della mia redenzione e mi devo denudare per… per mostrarti di quante piaghe è coperto il mio cuore. E… e tu sei una madre… e la sua Madre… Avrai dunque pietà di me».
«Sì, figlia».
«Oh! sì! Dimmi figlia!… Avevo una madre… e l’ho abbandonata… Mi hanno detto poi che è morta di dolore… Avevo un padre… mi ha maledetta… e dice a quelli della città: “Non ho più figlia”»… (il pianto riprende violento. Maria impallidisce di pena. Ma le pone una mano sul capo per confortarla). La velata riprende: «Non avrò più nessuno che mi chiami figlia!… Sì, così, carezzami così, come faceva la mamma mia… quando ero pura e buona… Lascia che io ti baci questa mano e mi asciughi con essa il pianto. Il mio pianto solo non mi lava. Quanto ho pianto da quando ho capito!… Prima anche avevo pianto, perché è orrore essere soltanto una carne sfruttata, insultata dall’uomo. Ma erano pianti di bestia malmenata che odia e si rivolta a chi la tortura, e sporcavano sempre più perché… cambiavo padrone ma non cambiavo bestialità… Da otto mesi io piango… perché ho capito… Ho capito la mia miseria, il mio marciume. Ne sono coperta e satura e ne ho nausea… Ma il mio pianto sempre più cosciente non mi lava ancora. Si mescola al mio marciume e non lo leva. Oh! Madre! Asciugami tu dal pianto, ed io sarò mondata in modo di poter avvicinare il mio Salvatore!».
«Sì, figlia, sì. Siedi. Qui, con me. E parla con pace. Lascia tutto il tuo peso, qui, su questi miei ginocchi di Madre», e Maria si siede.
168.3 Ma la velata le scivola ai piedi volendo parlarle così. Comincia piano: «Sono di Siracusa… Ho ventisei anni… Ero figlia di un intendente, direste voi, noi diciamo del procuratore di un grande signore romano. Ero figlia unica. Vivevo felice. Abitavamo presso la marina nella villa bellissima di cui mio padre era intendente. Ogni tanto veniva il padrone della villa, o sua moglie, e i figli… Ci trattavano bene ed erano buoni con me. Le fanciulle giocavano con me… Mia mamma era felice… era orgogliosa di me. Ero bella… ero intelligente… tutto mi riusciva facile… Ma amavo più le cose frivole delle cose buone. A Siracusa vi è un grande teatro. Un grande teatro… Bello… vasto… Serve ai giuochi e alle commedie… Nelle commedie e tragedie che in esso si danno sono molto usate le mime. Esse sottolineano con le loro mute danze il significato del coro. Tu non sai… ma anche con le mani, con le mosse del corpo possiamo esprimere i sentimenti dell’uomo agitato da qualche passione… Giovanetti e fanciulle vengono istruiti ad esser mimi in un’apposita palestra. Devono essere belli come dèi e agili come farfalle… A me piaceva molto andare su una specie d’altura da cui si dominava questo luogo e vedere le danze delle mime. E poi le rifacevo sui prati fioriti, sulle sabbie bionde della mia terra, nel giardino della villa. Parevo una statua d’arte, oppure un vento che trasvola, tanto sapevo fissarmi in pose statuarie o trasvolare quasi non toccando il suolo. Le mie ricche amiche mi ammiravano… e la mamma mia ne era orgogliosa…».
La velata parla, ricorda, rivede, sogna il passato e piange. I singhiozzi sono le virgole nel suo dire.
«Un giorno… era maggio… tutta Siracusa era in fiore. Da poco erano finite le feste ed io ero rimasta entusiasta di una danza eseguita nel teatro… Mi ci avevano portato, con le loro figlie, i padroni. Avevo quattordici anni… In quella danza le mime, che dovevano rappresentare le ninfe di primavera accorrenti ad adorare Cerere, danzavano incoronate di rose, vestite di rose… Di quelle sole, perché la veste era un velo leggerissimo, una rete di fili di ragno su cui erano sparse rose… Nella danza parevano alate Ebi tanto scorrevano leggere, gli splendidi corpi apparendo dalle scomposte sciarpe di velo fiorito che facevano ali dietro di loro… Studiai la danza… e un giorno… un giorno…».
168.4 La velata piange ancor più forte… Poi si riprende.
«Ero bella. Lo sono. Guarda». Sorge in piedi gettando rapida indietro il velo e lasciando ricadere il mantellone. E resto di stucco io, perché vedo emergere dalle stoffe respinte Aglae, bellissima pur nella dimessa veste, nella semplice acconciatura a trecce, senza gioielli, senza pompose stoffe, un vero fiore di carne, snello e pur perfetto, dal volto bellissimo, di un bruno pallido e dagli occhi di velluto ma pieni di fuoco.
Si torna a inginocchiare davanti a Maria: «Ero bella, per mia sventura. Ed ero folle. Quel giorno mi vestii di veli, mi aiutarono le fanciulle mie signore che amavano vedermi danzare… Mi vestii su un lembo di spiaggia bionda, in faccia all’azzurro mare. Sulla spiaggia, in quel luogo deserta, erano selvaggi fiori bianchi e gialli dal profumo acuto di mandorla, di vaniglia, di carne appena monda. Anche dagli agrumeti venivano ondate di profumo acuto, e odoravano i roseti siracusani, anche il mare, anche la rena odoravano; il sole traeva odore da tutte le cose… un che di panico che mi andava al capo. Mi sentivo ninfa io pure e adoravo… chi? La Terra feconda? Il Sole fecondatore? Non so. Pagana fra i pagani credo adorassi il Senso, il mio dispotico re che non sapevo di avere ma che era potente più di un dio… Mi incoronai delle rose prese nel giardino… e danzai… Ero ebbra di luce, di profumi, del piacere di essere giovane, agile e bella. Danzai… e fui vista. Vidi di essere guardata. Ma non mi vergognai di apparire nuda al cospetto di due occhi avidi di uomo. Anzi mi compiacqui di aumentare i miei voli… Il compiacimento di essere ammirata mi metteva veramente le ali… E fu la mia rovina. Tre giorni dopo rimasi sola perché i padroni erano partiti per tornare nella loro patrizia dimora di Roma. Ma non rimasi in casa… Quei due occhi ammiratori mi avevano svelato un’altra cosa oltre la danza… Mi avevano svelato il senso e il sesso».
Maria ha un atto di disgusto involontario che Aglae avverte.
«Oh! ma tu sei pura! E forse io ti ripugno…».
«Parla, parla, figlia. Meglio a Maria che a Lui. Maria è mare che lava…».
«Sì. Meglio a te. Me lo dissi io pure quando seppi che Egli aveva una madre… Perché prima, vedendolo tanto diverso da ogni uomo, l’unico tutto spirito – ora so che lo spirito c’è, e cosa è – prima non avrei potuto dire di che era fatto il tuo Figlio, così senza sensualità pur essendo uomo, e dentro di me pensavo non avesse madre, ma fosse sceso così, sulla Terra, per salvare le orrende miserie di cui io sono la più grande…
168.5 Tutti i giorni tornai in quel luogo sperando rivedere quell’uomo giovane, bruno, bello… E dopo qualche tempo lo rividi… Mi parlò. Mi disse: “Vieni con me a Roma. Ti porterò alla corte imperiale, sarai la perla di Roma”. Dissi: “Sì. Sarò la tua moglie fedele. Vieni dal padre mio”. Rise beffardo e mi baciò. Disse: “Non moglie. Ma tu dea ed io tuo sacerdote che svelerò a te stessa i segreti della vita e del piacere”. Ero folle, ero fanciulla. Ma per quanto fanciulla non ignoravo cosa è la vita… ero scaltra. Ero folle, ma non depravata ancora… e ne ebbi schifo della sua proposta. Gli sfuggii dalle braccia correndo a casa… Ma non parlai alla madre… e non seppi resistere al desiderio di rivederlo… I suoi baci mi avevano resa ancor più folle… E tornai… Non ero che appena tornata nella spiaggia solitaria che egli mi abbracciò baciandomi con frenesia, una pioggia di baci, di parole di amore, di domande: “Non è tutto in questo amore? Non è più dolce di un legame? Che altro vuoi? Puoi vivere senza di questo?”.
Oh! Madre!… Fuggii la stessa sera con il lurido patrizio… e fui il cencio che si calpesta sotto la sua animalità… Non dea: fango. Non perla: sterco. Non mi si rivelò la vita, ma la lordura della vita, l’infamia, lo schifo, il dolore, la vergogna, l’infinita miseria di non essere più neanche mia… E poi… la caduta totale. Dopo sei mesi di orgia, stanco di me, egli passò a nuovi amori e fui della strada. Sfruttai la mia capacità di danzatrice… Sapevo ormai che mia madre era morta di dolore e che non avevo più casa, più padre… Mi accolse nel suo ginnasio un maestro di danze. Mi perfezionò… mi godette… e mi lanciò come un fiore esperto di ogni arte del senso in mezzo al corrotto patriziato di Roma. Il fiore, già sporco, cadde in una cloaca. Sono dieci anni di discesa nell’abisso. Sempre più in basso. Poi fui portata qui per rallegrare gli ozi di Erode e qui venni presa dal nuovo padrone. Oh! non c’è cane tenuto a catena più cane incatenato di una di noi! E non c’è padrone di canizza più brutale dell’uomo che possiede una donna! Madre… tu tremi! Ti faccio orrore!».
Maria si è portata la mano al cuore come ne avesse ferita. Ma risponde: «No. Non tu. Mi fa orrore il Male che è tanto signore sulla Terra. Continua, povera creatura».
«Mi portò a Ebron… Ero libera? Ero ricca? Sì, poiché non ero nella carcere e poiché affogavo nei gioielli. No, perché non potevo vedere che chi egli voleva e non possedevo neppure più il diritto su me stessa.
168.6 Un giorno è venuto a Ebron un uomo: l’Uomo, tuo Figlio.
Quella casa gli era cara. Lo seppi e lo invitai ad entrare. Sciammai non c’era… e dalla finestra io avevo già udito parole e visto un aspetto che mi avevano sconvolto il cuore. Ma ti giuro, o Madre, che non fu la carne quella che mi spinse al tuo Gesù. Fu quella cosa che Egli mi rivelò che mi spinse sulla soglia, sfidando i lazzi del volgo, per dirgli: “Entra”. Fu l’anima che seppi allora di avere. Mi disse: “Il mio Nome vuol dire: Salvatore. Salvo chi ha buona volontà di salvezza. Salvo insegnando ad essere puri, a volere il dolore ma l’onore, il Bene ad ogni costo. Io sono Colui che cerca i perduti, che dà la Vita. Io sono Purezza e Verità”. Mi disse che anche io avevo un’anima e che l’avevo uccisa col mio modo di vivere. Ma non mi maledì, non mi derise. E non mi guardò mai! Il primo uomo che non mi succhiò con lo sguardo avido, perché ho con me la tremenda maledizione di attirare l’uomo… Mi disse che chi lo cerca lo trova perché Egli è dove è bisogno di medico e di medicina. E se ne andò. Ma le sue parole erano qui. E non sono più uscite. Mi dicevo: “Il suo Nome vuole dire Salvatore” come per cominciare a guarire. Mi erano rimaste le sue parole e i suoi amici pastori. E feci il primo passo dando obolo ad essi e chiedendo preghiera… E poi… fuggii… Oh! santa fuga questa! Fuggii il peccato in cerca del Salvatore. Andai cercando. Certa di trovarlo perché Egli me lo aveva promesso. Mi mandarono da un uomo di nome Giovanni come fosse Lui. Ma non era. Un ebreo mi indirizzò all’Acqua Speciosa. Vivevo vendendo il molto oro che avevo. Nei mesi che ero stata vagante avevo dovuto tener coperto il mio volto per non essere ripresa e perché, realmente, Aglae era sepolta sotto quel velo. Morta la antica Aglae. Vi era sotto la sua anima ferita e dissanguata che cercava il suo medico. Molte volte dovetti sfuggire al senso del maschio che mi perseguiva anche così annullata nella mia veste. Anche uno degli amici di tuo Figlio…
168.7 All’Acqua Speciosa vivevo come una bestia, povera ma felice. E le rugiade e il fiume mi mondarono meno delle sue parole. Oh! non una si è persa! Una volta perdonò ad un uomo assassino. Udii… e fui per dire: “Perdona a me pure”. Un’altra parlò dell’innocenza perduta… Oh! che pianto di rimpianto! Un’altra guarì un lebbroso… e fui per gridare: “Monda me dal mio peccato…”. Un’altra guarì un folle, e romano era… e piansi… e mi fece dire che le patrie passano ma il Cielo resta. Una sera di tempesta mi accolse nella casa… e poi mi fece ospitare dal fattore… e da un bambino mi fece dire: “Non piangere”… Oh! sua bontà! Oh! mia miseria! Tanto grandi ambedue che non osai portare la mia miseria ai suoi piedi… nonostante un dei suoi mi istruisse nella notte sulla infinita misericordia del tuo Figlio. E poi, insidiato da chi vedeva peccato nel desiderio di un’anima rinata, il mio Salvatore è partito… ed io l’ho atteso… Ma lo attendeva anche la vendetta di chi è ben ancora più indegno di me di guardarlo. Perché io ho peccato da pagana contro me stessa, mentre essi peccano, già conoscendo Dio, contro il Figlio di Dio… e mi hanno percossa… e più che con le pietre mi hanno ferita con l’accusa, e più che nella carne mi hanno ferita nella povera anima mia, portandola alla disperazione.
Oh! lotta tremenda con me stessa! Lacera, sanguinante, ferita, febbrile, senza più il mio Medico, senza tetto, né pane, ho guardato indietro, avanti… Il passato mi diceva: “Torna”, il presente mi diceva: “Ucciditi”, il futuro mi diceva: “Spera”. Ho sperato… Non mi sono uccisa. Lo farei se Egli mi cacciasse, perché non voglio più essere ciò che ero!… Mi sono trascinata in un paese chiedendo ricovero… Ma sono stata riconosciuta. Come una bestia ho dovuto fuggire, qua, là, sempre inseguita, sempre schernita, sempre maledetta, perché volevo essere onesta e perché avevo deluso coloro che, col mio mezzo, volevano colpire tuo Figlio. Seguendo il fiume sono risalita fino alla Galilea e sono venuta qui… Tu non c’eri… Sono andata a Cafarnao. Ne eri appena partita. Ma mi vide un vecchio. Uno dei suoi nemici, e mi ha fatto testo d’accusa per Lui, tuo Figlio, e poiché io piangevo senza reagire mi ha detto… mi ha detto…: “Tutto potrebbe cambiare per te se volessi essere mia amante e mia complice nell’accusare il Rabbi nazareno. Basta che tu dica, davanti ai miei amici, che Egli era il tuo amante…”. Sono fuggita come colui che vede aprirsi un cespuglio di fiori sotto lo snodarsi del serpe.
168.8 Io ho compreso così che non posso più andare ai suoi piedi… e vengo ai tuoi. Ecco, calpestami, io sono fango. Ecco, scacciami, io sono la peccatrice. Ecco, dimmi il mio nome: meretrice. Tutto accetterò da te. Ma abbi pietà, tu, Madre. Prendi la mia povera anima sporca e portala a Lui. Nelle tue mani è delitto mettere la mia lussuria. Ma solo lì sarà protetta dal mondo che la vuole, e diverrà penitenza. Dimmi come devo fare. Dimmi cosa devo fare. Dimmi quale mezzo devo usare per non essere più Aglae. Cosa devo mutilare in me? Cosa devo strappare da me per non essere più peccato, più seduzione, per non avere più a temere di me stessa e dell’uomo? Mi devo strappare gli occhi? Mi devo bruciare le labbra? Mi devo tagliare la lingua? Occhi, labbra, lingua mi hanno servito nel male. Non voglio più il male e sono disposta a punire me e loro col sacrificarli. O vuoi che mi strappi questi lombi avidi che mi hanno spinta ai pravi amori? Queste viscere insaziabili di cui temo sempre un risveglio? Dimmi, dimmi come si fa a dimenticarsi di essere femmine e come si fa a far dimenticare che si è femmine!».
Maria è sconvolta. Piange, soffre, ma del suo dolore non sono segno che le lacrime che cadono sulla pentita.
«Io voglio morire perdonata. Io voglio morire non ricordando altro che il Salvatore. Io voglio morire con la sua Sapienza a mia amica… e non posso più andargli vicino perché il mondo guata Lui e me per accusarci…». Aglae piange gettata del tutto a terra, come uno straccio.
168.9 Maria si alza in piedi mormorando: «Come è difficile essere redentori!». Affanna quasi.
Aglae, che sente il mormorio e intuisce l’atto, geme: «Lo vedi? Lo vedi che anche tu hai ribrezzo? Ora me ne vado. È finita per me!».
«No, figlia. Non è finita. Ora per te ha inizio. Ascolta, povera anima. Non gemo per te. Ma per il mondo crudele. Non ti lascio andare, ma ti raccolgo, povera rondine sbattuta dalla bufera contro le mie pareti. Io ti porterò da Gesù ed Egli ti dirà la tua via di redenzione…».
«Non spero più… Il mondo ha ragione. Non posso essere perdonata».
«Dal mondo no. Ma da Dio sì. Lascia che io ti parli in nome del supremo Amore che mi ha dato un Figlio perché io lo doni al mondo. Mi ha tratto dalla beata ignoranza della mia verginità consacrata perché il mondo avesse il Perdono. Mi ha tratto non sangue dal parto ma dal cuore col rivelarmi che la mia Creatura è la Gran Vittima. Guardami, figlia. In questo cuore è una grande ferita. Geme da trenta e più anni e sempre più si allarga e mi consuma. Sai che nome ha?».
«Dolore».
«No. Amore. È amore questo che mi svena per fare che non sia solo il Figlio nel salvare. È amore che mi dà fuoco perché io purifichi coloro che non osano andare al Figlio mio. È amore che mi dà pianto perché io lavi i peccatori. Tu volevi la mia carezza. Ti do le mie lacrime che ti fanno già bianca per potere guardare il mio Signore. Non piangere così! Non sei la sola peccatrice che viene al Signore e ne parte redenta. Altre ce ne furono, altre ce ne saranno.
Dubiti che Egli ti possa perdonare? Ma non vedi in ogni cosa che ti è avvenuta un misterioso volere della Bontà divina? Chi ti ha condotta in Giudea? Chi nella casa di Giovanni? Chi ti mise alla finestra quella mattina? Chi ti accese una luce per illuminarti le sue parole? Chi ti diede la capacità di comprendere che la carità, unita alla preghiera del beneficato, ottengono aiuto divino? Chi ti diede forza di fuggire dalla casa di Sciammai? Chi di perseverare nelle prime giornate fino al suo arrivo? Chi ti portò sulla sua via? Chi ti fece capace di vivere da penitente per mondare sempre più l’anima tua? Chi ti rese anima di martire, anima di credente, anima di perseverante, anima di pura?… Sì, non scuotere il capo. Credi tu che sia puro solo chi non ha conosciuto il senso? Credi tu che l’anima non possa tornare mai più vergine e bella? Oh! figlia! Ma fra la mia purezza che è tutta grazia del Signore e la tua eroica ascesa a ritroso verso la vetta della tua purezza perduta, credi che è più grande la tua. Tu la costruisci: contro il senso, il bisogno e l’abitudine. Per me è la dote naturale come il respiro. Tu devi stroncare il pensiero, gli affetti, la carne, per non ricordare, per non appetire, per non secondare. Io… oh! può mai una creaturina di poche ore desiderare la carne? E ne ha merito di non farlo? Così io. Io non so che sia questa tragica fame che ha fatto dell’umanità una vittima. Io non so altro che la santissima fame di Dio. Ma tu questa non la conoscevi e da te l’hai appresa. Ma tu l’altra, tragica e orrenda, l’hai domata per amore di Dio, tuo unico amore ora. Sorridi, figlia della Misericordia divina! Mio Figlio fa in te ciò che ti ha detto ad Ebron. Lo ha già fatto. Tu sei già salvata perché hai avuto buona volontà di salvarti, perché hai appreso la purezza, il dolore, il Bene. L’anima è rinata. Sì. Ti occorre la sua parola per dirti in nome di Dio: “Sei perdonata”. Io questo non lo posso dire. Ma ti do il mio bacio a promessa, a principio di perdono… O Spirito eterno, un poco di Te è sempre nella tua Maria! Lascia che Ella ti effonda, Spirito santificatore, sulla creatura che piange e che spera. Per il nostro Figlio, o Dio d’amore, salva costei che da Dio attende salvezza. La Grazia, di cui disse l’Angelo che Dio mi ha colmata, si posi per un miracolo su costei e la sorregga sinché Gesù, il Salvatore benedetto, il supremo Sacerdote, l’assolverà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito…
168.10 È notte, figlia. Sei stanca e lacera. Vieni. Riposa. Domani partirai… Ti manderò presso una famiglia di onesti. Perché qui troppi vengono ormai. E ti darò una veste in tutto simile alla mia. Sembrerai un’ebrea. E poiché rivedrò mio Figlio solo in Giudea, perché la Pasqua si approssima e al novilunio di aprile saremo a Betania, parlerò allora di te. Vieni alla casa di Simone lo Zelote. Mi troverai e ti porterò a Lui».
Aglae piange ancora. Ma ora con pace. Si è seduta per terra. Anche Maria si è tornata a sedere. E Aglae le posa la testa sui ginocchi e bacia la mano di Maria… Poi geme: «Mi riconosceranno…».
«Oh! no. Non temere. Il tuo abito era ormai troppo noto. Ma io ti preparerò per questo tuo viaggio verso il Perdono e sarai come la vergine che va a nozze: diversa e ignota per la folla ignara del rito. Vieni. Ho una piccola camera presso la mia. Vi hanno alloggiato santi e pellegrini desiderosi di andare a Dio.
Ospiterà anche te».
Aglae fa per raccogliere il mantellone e il velo.
«Lascia. Sono le vesti della povera Aglae sperduta. Essa non è più… e neppure più deve di lei rimanere la veste. Ha sentito troppo odio… e fa male l’odio quanto il peccato».
Escono nell’orto oscuro, entrano nella cameretta di Giuseppe. Maria accende la lucernetta che è su una mensola, carezza ancora la pentita, chiude la porta e colla sua triplice fiammella si illumina per vedere dove portare il mantello sdruscito di Aglae acciò nessun visitatore domani lo veda.
10 È notte, figlia. Sei stanca e lacera. Vieni. Riposa. Domani partirai… Ti manderò presso una famiglia di onesti. Perché qui troppi vengono ormai. E ti darò una veste in tutto simile alla mia. Sembrerai un'ebrea. E poiché rivedrò mio Figlio solo in Giudea, perché la Pasqua si approssima e al novilunio di aprile saremo a Betania, parlerò allora di te. Vieni alla casa di Simone lo Zelote. Mi troverai e ti porterò a Lui».
Aglae piange ancora. Ma ora con pace. Si è seduta per terra. Anche Maria si è tornata a sedere. E Aglae le posa la testa sui ginocchi e bacia la mano di Maria… Poi geme: «Mi riconosceranno…»
«Oh! no. Non temere. Il tuo abito era ormai troppo noto. Ma io ti preparerò per questo tuo viaggio verso il Perdono e sarai come la vergine che va a nozze: diversa e ignota per la folla ignara del rito. Vieni. Ho una piccola camera presso la mia. Vi hanno alloggiato santi e pellegrini desiderosi di andare a Dio. Ospiterà anche te».
Aglae fa per raccogliere il mantellone e il velo.
«Lascia. Sono le vesti della povera Aglae sperduta. Essa non è più… e neppure più deve di lei rimanere la veste. Ha sentito troppo odio… e fa male l'odio quanto il peccato».
Escono nell'orto oscuro, entrano nella cameretta di Giuseppe. Maria accende la lucernetta che è su una mensola, carezza ancora la pentita, chiude la porta e colla sua triplice fiammella si illumina per vedere dove portare il mantello sdruscito di Aglae acciò nessun visitatore domani lo veda.
 Voglio che le anime possano bere alla Fonte vitale della mia parola
Voglio che le anime possano bere alla Fonte vitale della mia parola